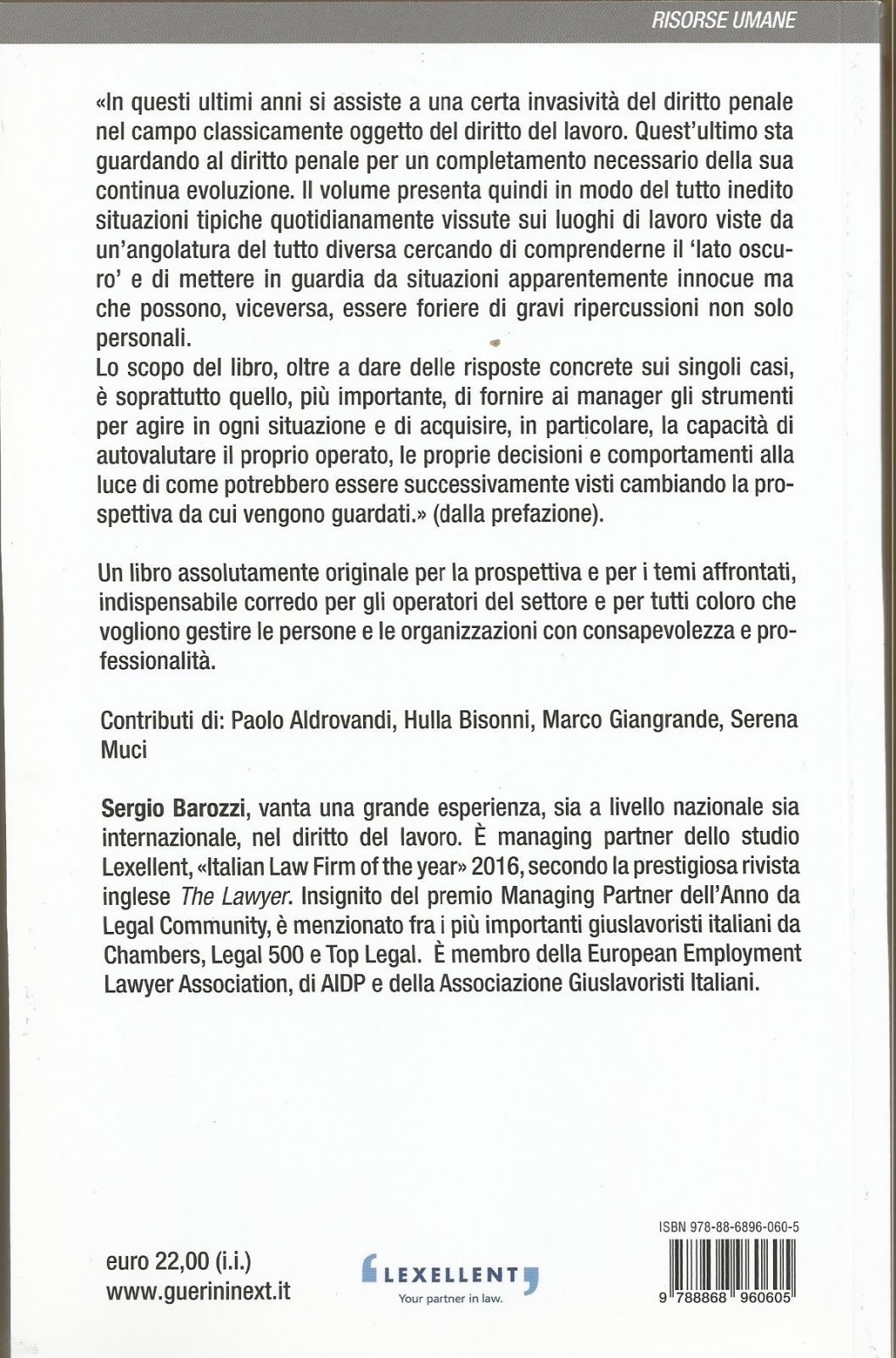Sempre sui riders (anche nella più ampia accezione di lavoratori “digitali”) per rilevare (ancora) che non ci siamo. A dimostrarlo due fatti recenti. L’entrata in vigore della legge della regione Lazio n. 4 del 2019 e la stipula di un accordo aziendale per disciplinare il rapporto di lavoro (subordinato) dei “fattorini telematici” in Toscana. La legge regionale, nel promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali, evidenzia chiari profili di incostituzionalità. L’accordo, nato con l’intento di disciplinare la figura professionale del rider, sembra fallire nei suoi intenti. Diventa allora sempre più urgente un intervento sistematico del legislatore nazionale. In attesa, quale strada è possibile seguire?
La legge della regione Lazio n. 4, del 12 aprile 2019 (in vigore dal successivo 17), tenta di promuovere la tutela della salute e sicurezza dei prestatori nell’ambito del “lavoro digitale”; la contrattazione collettiva locale (provincia di Firenze) firma un accordo aziendale con una neonata impresa di food delivery per disciplinare il rapporto di lavoro (subordinato) dei riders (20 in tutto, per ora), nella speranza che altri imprenditori facciano altrettanto.
Insomma, sempre di lavoro “povero” si finisce per parlare di questi tempi: fattorini, autisti, promotori, venditori, comunque bassa manovalanza “digitale”, costantemente in bilico fra subordinazione e autonomia, fra essere o non essere degni di tutela.
Nulla di clamoroso, invero, ma ce n’è abbastanza per scriverne ancora.
Riguardo all’iniziativa legislativa laziale, essa trae origine dalla volontà (tutta politica) di introdurre, in mancanza di una specifica normativa di livello nazionale, alcuni strumenti volti a tutelare la dignità, la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali.
Già a fronte di siffatta dichiarazione d’intenti, foriera di svariati problemi in ordine alla ripartizione della potestà legislativa Stato-Regioni, appare necessario soffermarsi, seppur brevemente sulla struttura del testo normativo.
Nello specifico, la legge (riecheggiando la “Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano della città metropolitana di Bologna) procede ad individuare i lavoratori digitali, quali destinatari delle tutele ivi previste definendoli (art. 2, c. 2), in modo volutamente assai astratto, come coloro che, “indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offrono la disponibilità della propria attività di servizio all’impresa, di seguito denominata piattaforma digitale, che organizza l’attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l’utilizzo di un’applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo”. Il Capo II declina i fondamentali aspetti di tutela (anche) di tali lavoratori, ossia: salute e sicurezza (art. 3); assistenza e previdenza (art. 4); compenso e indennità speciali (art. 5); informativa preventiva in ordine a salute e sicurezza e modalità di esecuzione del rapporto (art. 6); parità di trattamento e non discriminazione nella determinazione del (proprio) rating reputazionale, ossia della customer satisfaction, vale a dire del giudizio valutativo del servizio da parte del cliente finale (art. 7). Chiude il Capo l’apparato sanzionatorio amministrativo pecuniario (da 500 a 2000 €) finalizzato alla repressione degli obblighi di cui sopra (art. 8).
Analizzando, più in particolare, i singoli articoli, si evidenzia come, ex art. 3, la Giunta, sentiti la Commissione consiliare competente e il Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 81/2008, individua, con propria deliberazione, le misure dirette a promuovere la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, con il coinvolgimento delle piattaforme digitali, le quali, “nel rispetto della normativa vigente in materia e al fine di garantire al lavoratore digitale la tutela piena e integrale contro gli infortuni nell’attività di servizio”, devono adottare “interventi e misure per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale e, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall’esercizio dell’attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione”.
Le stesse piattaforme digitali, inoltre, con oneri a proprio carico, sono tenute a fornire al lavoratore digitale dispositivi di protezione (cd. “DPI”) conformi alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché a provvedere alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti (spesso, se non sempre, di proprietà dei lavoratori) utilizzati per l’attività di servizio.
Importanti (e confuse) sono altresì le prescrizioni contenute nel successivo art. 4, a tenore del quale grava sulle piattaforme digitali l’onere di stipulare un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei lavoratori digitali, per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di servizio, nonché quella, non meglio identificata, “per la tutela della maternità e della paternità”, senza franchigia a carico del lavoratore, il quale ha, inoltre, diritto alla tutela previdenziale obbligatoria “secondo quanto disposto dalla normativa nazionale” (presumibilmente in relazione alla specifica e concreta tipologia di rapporto di lavoro stipulato).
Altro onere gravante sulle piattaforme digitali meritevole di un breve cenno, è quello relativo alla predisposizione di un’informativa preventiva che illustri al lavoratore digitale:
– i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del lavoro di servizio;
– il luogo in cui è svolta l’attività di servizio;
– l’oggetto dell’attività di servizio;
– il compenso (non inferiore alla misura oraria minima, con eventuali maggiorazioni per determinate situazioni, prevista dai CCL, con espressa esclusione del cottimo) e le indennità speciali (indennità di prenotazione)
– gli strumenti di protezione assegnati;
– le modalità con cui l’algoritmo determina l’incontro fra la domanda e l’offerta di servizio;
– la procedura di verifica imparziale del rating reputazionale del lavoratore.
Il Capo III individua invece “gli strumenti” amministrativi e operativi di cui la Regione si avvarrà per dialogare con tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore, fornendo loro servizi di supporto attraverso la creazione di un “Portale del lavoro digitale”, composto dall’anagrafe regionale dei lavoratori digitali e dal registro regionale delle piattaforme digitali.
Le piattaforme (se in regola con le disposizioni contenute nella legge) e i lavoratori digitali potranno iscriversi gratuitamente accedendo al programma annuale degli interventi aventi ad oggetto:
– l’informazione sui diritti;
– la formazione in materia di salute e di sicurezza;
– le forme di tutela integrativa in materia di previdenza e di assistenza.
La Regione promuove, inoltre, la stipula di accordi con INPS, INAIL e compagnie di assicurazione finalizzate ad attuare la disciplina delle tutele previdenziali e assicurative, nonché con l’INL per il monitoraggio e il controllo del lavoro digitale.
Ricostruiti gli obiettivi e i principali contenuti della Legge in commento, occorre adesso coglierne i profili di criticità.
Le perplessità sollevate attengono, essenzialmente, alla sua compatibilità con il sistema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost., come riformato dalla L. Cost. n. 3/2001.
La questione appena posta in luce, di soluzione tutt’altro che immediata, trae origine dalla discussa collocazione delle materie di interesse lavoristico nell’impianto ripartitorio scolpito nel citato art. 117 Cost.
Tale norma, al c. 2, rimette all’esclusiva competenza statale il potere di legiferare nei seguenti ambiti: “ordinamento civile e penale” (lett. L), “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. M), “previdenza sociale” (lett. O), mentre, al c. 3, individua, devolvendole alla legislazione concorrente, talune materie che intercettano a vario titolo il diritto del lavoro, tra cui “tutela e sicurezza del lavoro”, “previdenza complementare e integrativa” e “tutela della salute”, stabilendo, poi, al c. 4, che le materie residuali (non attribuite alla potestà esclusiva dello Stato ovvero a quella concorrente Stato – Regioni) vanno rimesse, in via sussidiaria, alla competenza legislativa regionale.
Ciò posto, è agevole intuire come le incertezze sottese alla devoluzione del potere legislativo in materia di lavoro dipendano, in particolare, quanto meno da due fattori: da un lato, l’equivocità della formula “tutela e sicurezza del lavoro”; dall’altro, la difficoltà di far convivere, senza interferenze, l’intervento esclusivo dello Stato e quello concorrente Stato – Regioni in un panorama di materie spesso dotate di confini non definiti, variabili e, per giunta, destinati a intersecarsi.
Proprio tali due profili di criticità, per l’appunto, stanno alla base della dubbia legittimità costituzionale della legge in commento.
Vediamone le ragioni.
Il primo dato, di certo non destinato a passare inosservato, consiste nel rilievo per cui la disciplina regionale appena entrata in vigore intende innanzitutto promuovere la tutela della salute e la sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro protetto e dignitoso, nel rispetto, tra gli altri, proprio dell’art. 117, c. 3, Cost.
Nonostante il legislatore regionale dichiari di agire nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione in tema di competenza normativa concorrente, non appare che ciò sia, in realtà, avvenuto.
Infatti, posto che, come sopra richiamato, la Costituzione include la materia della “tutela e sicurezza del lavoro” tra quelle di legislazione concorrente, v’è da rilevare come la stessa giurisprudenza costituzionale sia in passato intervenuta a delimitare l’effettiva portata del potere legislativo regionale in tale settore.
A questo proposito, in particolare, il Giudice delle leggi ha chiarito che, in concreto, compete alle Regioni soltanto la disciplina dell’organizzazione del mercato del lavoro, nell’accezione del “collocamento” e delle “politiche attive del lavoro”, restando escluse da questo ambito, di esclusiva pertinenza del legislatore nazionale, tutte le norme che incidono sulle reciproche obbligazioni che sorgono tra le parti di un contratto di lavoro.
Si tratta di principi che, in realtà, non sembrano rispettati dalla legge della Regione Lazio: in particolare, è dall’analisi del Capo II (il Capo III, di tipo promozionale, pare, tutto sommato, compatibile) che si evince come il legislatore territoriale sia intervenuto su aspetti fondamentali del rapporto di lavoro, incorrendo così nell’abusodella propria potestà normativa per come intesa nell’interpretazione del giudice costituzionale.
Il rispetto soltanto formale del dato costituzionale si evince, nello specifico, dall’intenzione del Legislatore regionale di disciplinare istituti in realtà riconducibili alla potestà esclusiva dello Stato perché rientranti in materie di cui all’art. 117, c. 2, Cost., quali l’ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la previdenza sociale.
Tra tali istituti rientrano, in particolare, il compenso spettante al lavoratore digitale ex art. 5, nonché le disposizioni relative alle tutele assistenziali e previdenziali a norma dell’art. 4, oltre che la previsione, di cui all’art. 8, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione delle prescrizioni poste dagli artt. 3 -7 della stessa legge.
Gli aspetti per i quali è possibile ipotizzare l’incostituzionalità della legge acquistano ancora più consistenza ove si consideri la mancata denominazione (intenzionale) del rapporto di lavoro dei riders da parte del legislatore regionale.
Il fatto cioè che la Regione non inquadri i lavoratori digitali come autonomi o subordinati, al di là del vizio originario della legge per carenza di potere normativo “a monte”, espone al rischio di antinomie tra i contenuti delle tutele ivi previste e la fisionomia di taluni istituti già disciplinati dal legislatore nazionale.
È da rilevare, infatti, come il legislatore regionale, così facendo, estenda, seppur genericamente, tutele tipiche del lavoro subordinato (ad esempio, quelle previdenziali ed assistenziali) a lavoratori la cui qualificazione giuridica è, in realtà, ancora incerta e, comunque, rimessa alla giurisdizione del lavoro.
In ultima analisi, al di là dei profili di incostituzionalità sopra adombrati, la legge in commento si presenta, anche e soprattutto, di dubbia opportunità alla luce delle osservazioni in termini di politica del diritto: sembra, infatti, che la stessa ponga le basi affinché il lavoro digitale sia destinatario di una regolamentazione tutt’altro che omogenea nel contesto nazionale, esponendo al rischio che la disciplina in materia venga affidata esclusivamente all’arbitrio dei singoli legislatori regionali, ingenerando tutt’altro che improbabili rischi di “dumping sociale” ancorché in una prospettiva eminentemente “rimediale”.
Le riflessioni in merito a quali siano gli strumenti oggi utilizzabili al fine di disciplinare il lavoro digitale si rivelano, inoltre, ancor più attuali, arricchendosi negli ultimi giorni, di un nuovo ambito di contrattazione collettiva.
Risale, infatti, allo scorso 8 maggio la notizia riguardante un’azienda fiorentina attiva (solo da un paio di mesi) nel settore della consegna di cibo a domicilio, la quale ha siglato con i sindacati locali (provincia di Firenze) un accordo di secondo livello finalizzato all’assunzione di 20 riders a tempo indeterminato, nonché al riconoscimento dei diritti spettanti al lavoratore subordinato: ciò sul fronte sia della retribuzione mensile, sia del diritto alle ferie, ai permessi o alle assenze per malattia e infortunio (tutte prerogative ancora non conferite, come anticipato, da norme nazionali valide in senso generale ed astratto, nei confronti di tali tipologie di lavoratori).
A destare perplessità è, anzitutto, la qualificazione formale del contratto in esame, intitolato, testualmente, “Verbale di accordo quadro – riders Toscana”. Scarsamente comprensibili sono le ragioni di tale dicitura.
L’incipit del testo in esame, infatti, enuncia la volontà delle parti di stabilire un accordo quadro sperimentale per la Provincia di Firenze e successivamente anche per la Regione Toscana. Ciò dichiarato sul piano delle aspettative di diffusione dell’iniziativa in oggetto, rimane comunque fermo cha a sottoscrivere l’accordo è stata unicamente la società datrice e non, invece, il complesso delle organizzazioni esponenziali di categoria: conseguentemente, nessun dubbio pare possa nutrirsi rispetto alla validità di tale atto nell’ambito, per ora, della sola azienda firmataria e non a livello regionale.
Ciò posto, l’accordo in oggetto, con il dichiarato intento di disciplinare la figura professionale del “rider” anche in relazione a nuovi modelli produttivi ed organizzativi introdotti dalla GIG economy, richiama il CCNL nazionale Merci, logistica e spedizioni (per come modificato dall’ipotesi di rinnovo risalente al dicembre 2017 che ha, tra l’altro, abolito il divieto di utilizzo del lavoro a chiamata) e, spiegano gli stessi sindacati, dovrebbe comportare, in favore dei neoriders fiorentini, il pagamento delle ore effettivamente lavorate e non in base alle consegne, utilizzando la cornice tipologica del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue (una sorta di variazione sul tema del lavoro intermittente) di cui ai Regi Decreti n. 692 e 2657 del 1923 (sia consentito sottolineare il paradosso che per regolare il lavoro dei “fattorini telematici” della GIG economy digitale, si debba fare riferimento e utilizzare norme pensate nel lontanissimo e “arcaico” 1923).
Questa affermazione, da un’analisi del medesimo accordo, si rileva, comunque, infondata.
Le previsioni negoziali, infatti, definiscono l’orario di lavoro del rider come il tempo dedicato a tutte le operazioni di trasporto del prodotto (ritiro, tragitto e consegna; v. Punto D, 1), aggiungendo poi che esulano dall’orario effettivo di lavoro tutti i tempi non ricompresi nel precedente punto 1 e che per i tempi di disponibilità è dovuto unicamente il trattamento di indennità oraria pari a 0,60 euro lordi (Punto D, 2).
Di conseguenza, in virtù delle previsioni richiamate, il rider avrà diritto alla retribuzione oraria prevista dal CCNL di categoria soltanto ove riceva ordini di consegna; per converso, qualora nessun utente del portale chieda di fruire del servizio a domicilio, al lavoratore sarà riservato il trattamento economico orario pari a 0,60 euro lordi.
Siffatta disciplina, in concreto, smentisce, quindi, le premesse annunciate in merito alla stima del compenso sulla base delle ore di lavoro e non, invece, in base a ciascuna consegna portata a compimento.
In attesa, dunque, di un intervento sistematico del legislatore nazionale inteso a tutelare il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”, e visti i richiamati profili di possibile e probabile incostituzionalità delle iniziative normative regionali, appare ragionevole ritenere che lo strumento più idoneo a disciplinare la materia in esame continui ad essere quello della contrattazione collettiva, anche di secondo livello; in tale caso, tuttavia, non sembra che l’accordo in commento abbia colto nel segno.






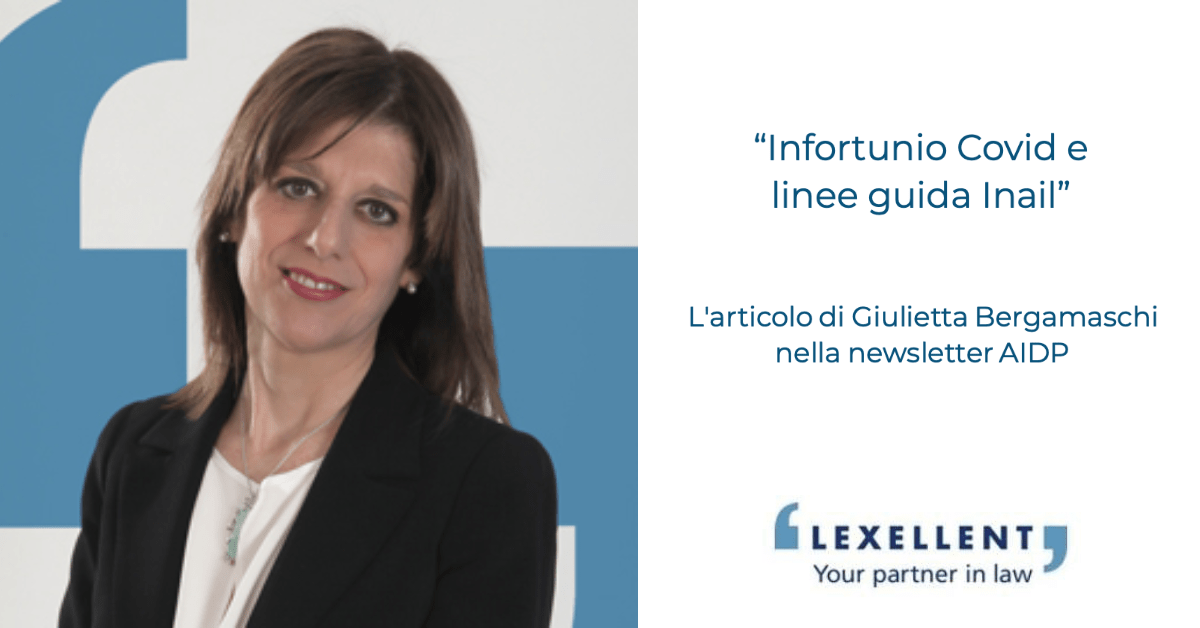














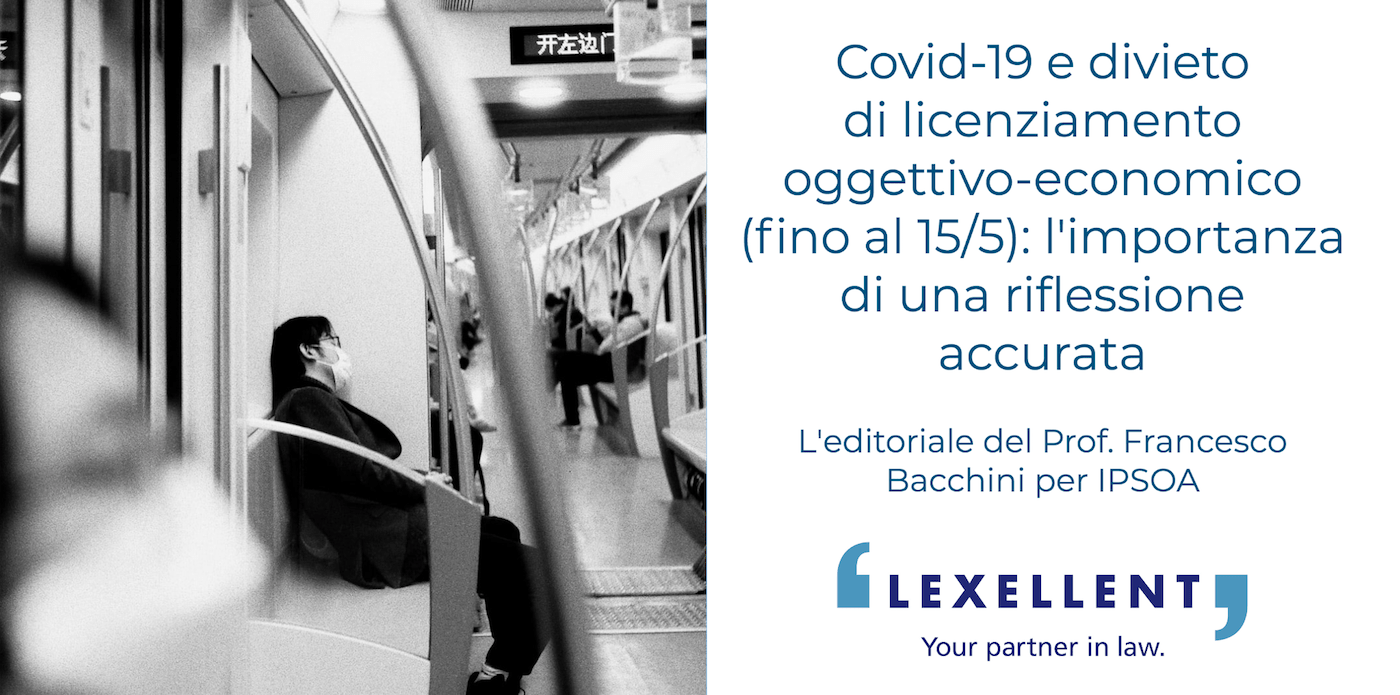




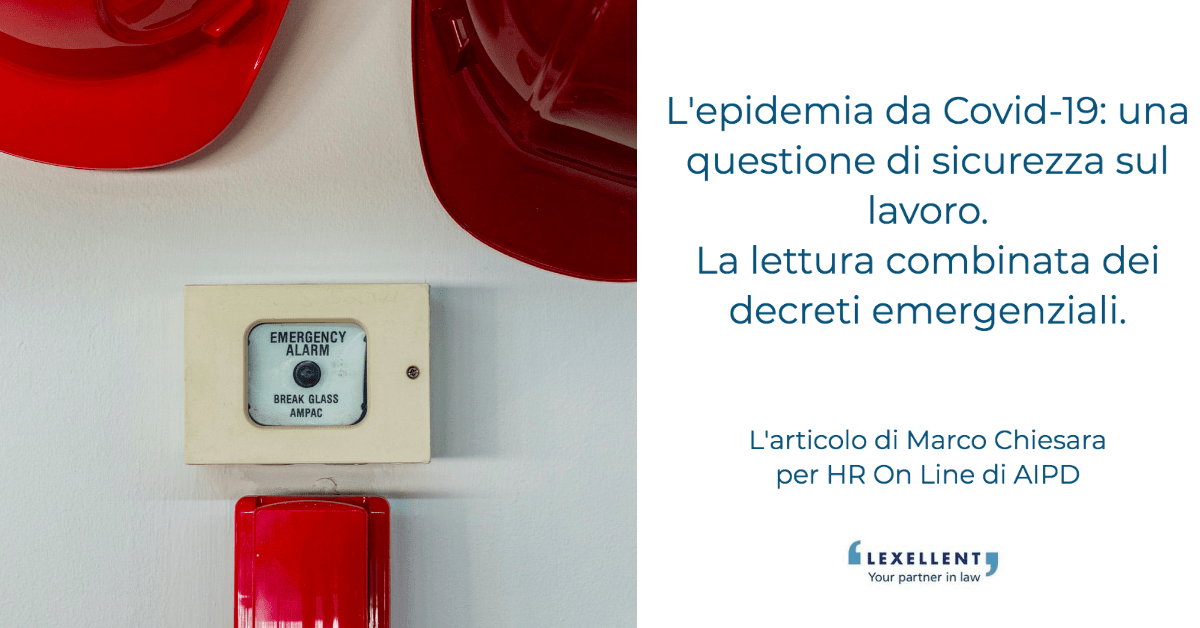






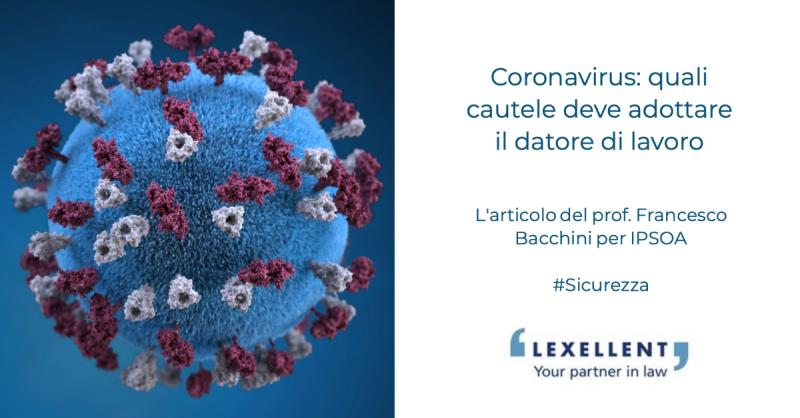







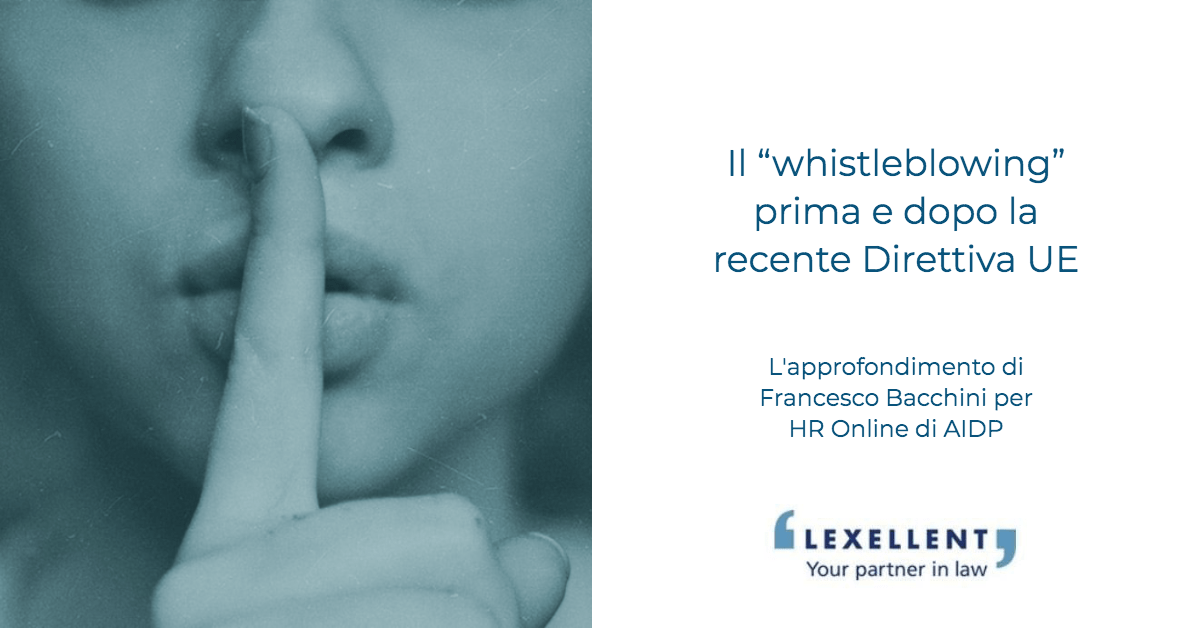




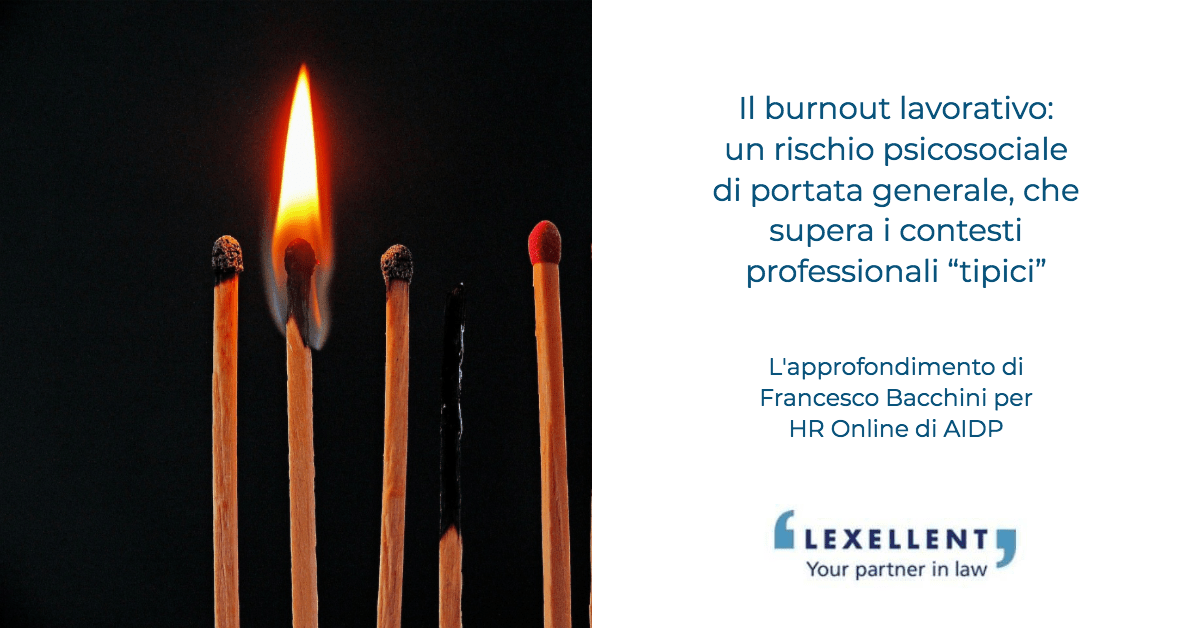
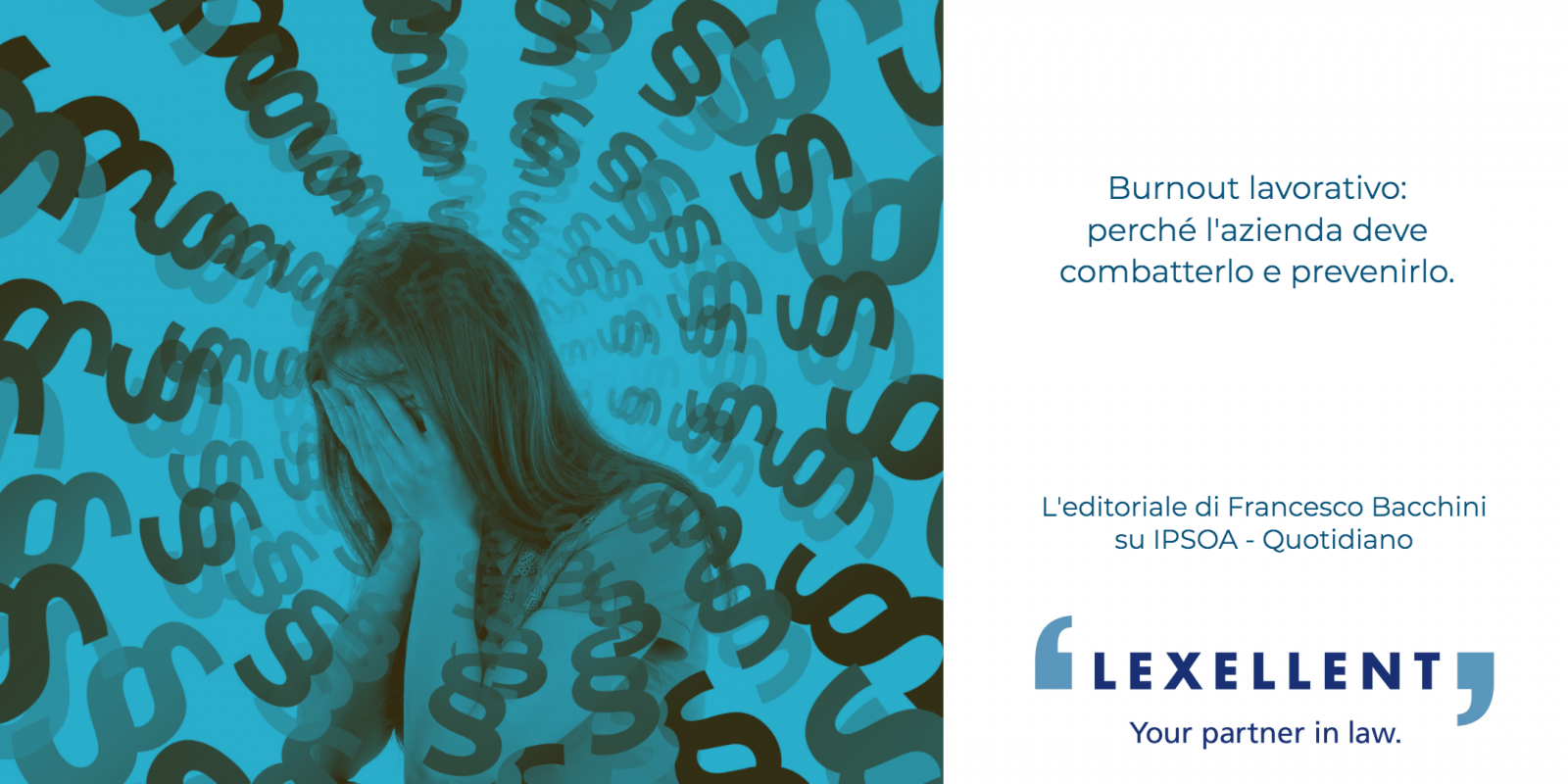


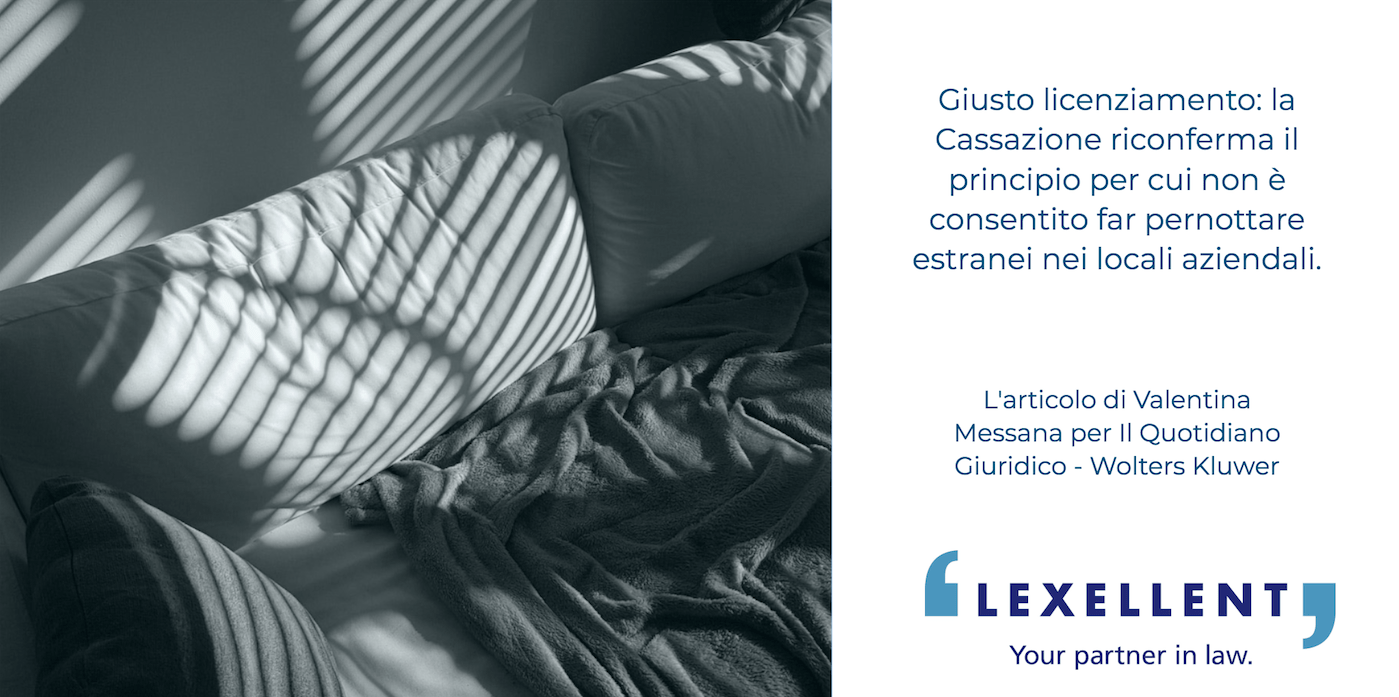


























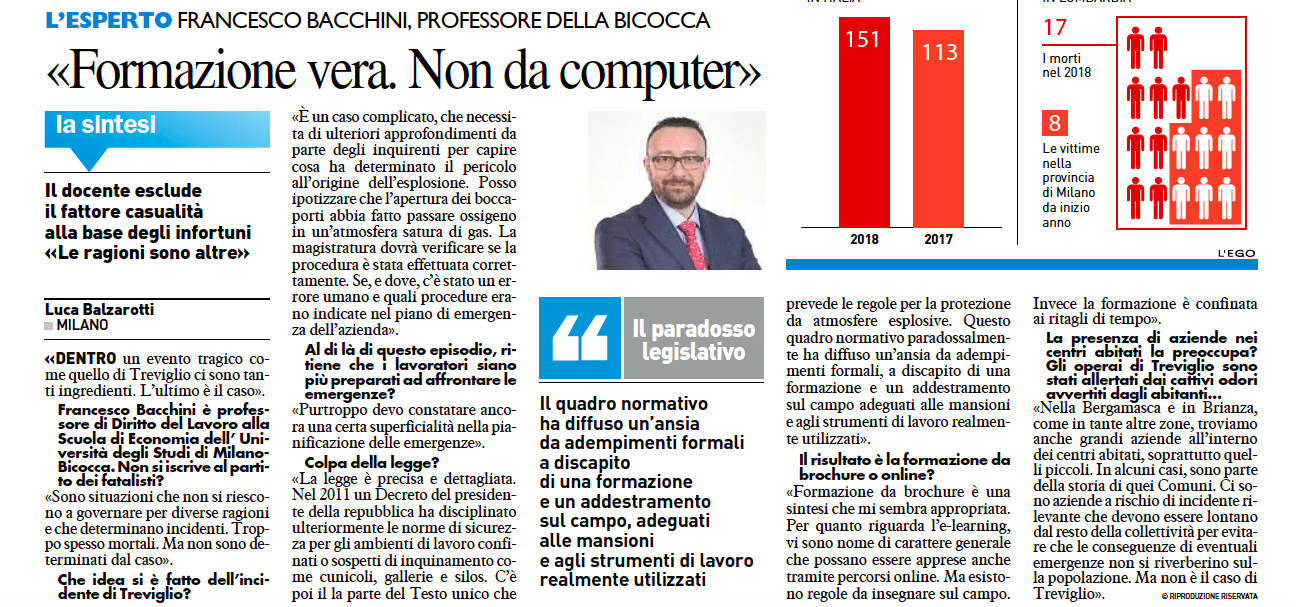








 Avvocata Bergamaschi, la legge sul lavoro agile è stata criticata per il fatto che è molto vaga. Lei che ne pensa?
Avvocata Bergamaschi, la legge sul lavoro agile è stata criticata per il fatto che è molto vaga. Lei che ne pensa?



 Giulietta Bergamaschi
Giulietta Bergamaschi
 Spesso, quando si parla dei valori dell’inclusione e della diversity in azienda gli interlocutori sembrano pensare che sia solo un argomento “buonista”, che riguarda solo un’eventuale sfera etica del lavoro e non aspetti molto precisi che toccano la produttività e i ricavi di un’azienda. Ma nelle stesse aziende ci capita sempre più spesso, per esempio, di sentire direttori del personale e amministratori delegati che affermano di aver urgente bisogno di «assumere persone qualificate con caratteristiche specifiche che, semplicemente, sul mercato non ci sono». Frasi del genere vengono ripetute talmente tante volte che probabilmente si tratta di un problema urgente e tutt’altro che secondario. Eppure manca la coscienza che una risposta possibile a quest’esigenza può venire proprio da un diverso approccio al problema della diversity.
Spesso, quando si parla dei valori dell’inclusione e della diversity in azienda gli interlocutori sembrano pensare che sia solo un argomento “buonista”, che riguarda solo un’eventuale sfera etica del lavoro e non aspetti molto precisi che toccano la produttività e i ricavi di un’azienda. Ma nelle stesse aziende ci capita sempre più spesso, per esempio, di sentire direttori del personale e amministratori delegati che affermano di aver urgente bisogno di «assumere persone qualificate con caratteristiche specifiche che, semplicemente, sul mercato non ci sono». Frasi del genere vengono ripetute talmente tante volte che probabilmente si tratta di un problema urgente e tutt’altro che secondario. Eppure manca la coscienza che una risposta possibile a quest’esigenza può venire proprio da un diverso approccio al problema della diversity.